Che cosa manca al burattino per diventare un bambino? Che cos’abbiamo noi che l’intelligenza artificiale non possieda? A credere a quel che si legge, niente: i computer pensano, e pensano meglio di noi, tanto è vero che ci portano via il lavoro.
Indice degli argomenti
Le differenze fondamentali tra mente e computer
Ma a rifletterci un poco, magari senza farci aiutare da loro, le differenze ci sono eccome. Ai computer manca la vita, dunque non muoiono, non hanno paura, non si annoiano, non si deprimono né si entusiasmano. Ai computer manca la volontà, dunque non prendono alcuna iniziativa, e ci vuole sempre un umano che li attivi con un prompt, un bisogno, una richiesta. Privi di vita e di volontà non possiedono nemmeno un mondo dello spirito, né una ragione come facoltà dei fini, e neanche un sospetto di coscienza o di inconscio.
Immagino che cosa state pensando, e cioè che adesso vi infligga la tirata sull’irriducibilità dell’umano in quanto benedetto dallo spirito o da qualcosa di simile. Ma non è così: se siamo quelli che siamo non è per un intervento soprannaturale, né per una dotazione naturale particolarmente vantaggiosa ma, proprio al contrario, perché da che uomo è uomo abbiamo a che fare con la tecnica, dal bastone da scavo all’intelligenza artificiale. A sorpresa dunque – attraverso vicende sotto gli occhi di tutti, eppure nascoste dall’inizio dei tempi – noi siamo umani, e come tali antitetici e complementari rispetto alla tecnica, proprio perché in ogni istante di una storia lunghissima (ma non infinita, purtroppo o per fortuna) abbiamo delegato delle nostre capacità a dei supporti esterni, che ce le hanno restituite potenziandoci a loro volta, rendendoci sempre più umani, dotandoci di stazione eretta, di linguaggio, di istituzioni, di scrittura e di tutto ciò senza cui saremmo solo degli animali particolarmente svantaggiati, e probabilmente estinti da chissà quanto tempo.
La metamorfosi impossibile del burattino in bambino
Sono andato troppo veloce, volevo dire tutto. Ma, se posso permettermi un consiglio interessato, suggerisco di proseguire la lettura. La metamorfosi di un burattino che diventa un bambino non ha nulla di semplice, tanto è vero che ci vuole la fata dai capelli turchini, la trasformazione di un pezzo di legno in un organismo, e (sempre più difficile) l’accesso al mondo del bene e del male: un mondo in cui ci sono i Carabinieri, il gatto e la volpe, Mangiafoco, l’omino di burro e il terribile pesce-cane. Certo, nell’età che crede – ma crede soltanto – di avere inventato l’intelligenza artificiale (c’era prima di Alan Turing, ma non sarà mai come la mente, non dico di un umano, ma di un castoro), siamo portati a confondere il burattino con il bambino; ed è piuttosto facile pensare che sia così, se è quello che vogliamo. Ma è sufficiente un esame superficiale della differenza tra l’anima, il bambino, e l’automa, il burattino, per concludere che solo in un circo, e davanti a un pubblico di bocca buona, il secondo potrà tramutarsi nella prima, e inversamente. Lo scrivo non tanto per aggiungere un’opinione in più a un dibattito plurisecolare, quanto piuttosto per porre le basi per il seguito del mio discorso, che prende l’artificiale come punto di vista per definire un naturale, la mente umana e il suo mondo, ancora più nascosto e problematico di quanto già non si sospetti.
La ricerca storica dell’anima nell’artificiale
Da quando si è fatto avanti il burattino (cioè pressappoco dall’epoca di Erone di Alessandria, che si congettura sia vissuto nel I secolo d.C.1, ma non dimentichiamo che queste sono solo le prime testimonianze che ci risultano), un automa battezzato nel 1956 con il nome suggestivo di «intelligenza artificiale», siamo andati a caccia delle sue analogie con l’anima, mossi da una passione antropomorfa. E, dopo Turing, l’inseguimento del bambino da parte del burattino – o meglio dei tanti burattinai che lo progettavano – si è fatto ancora più incalzante che ai tempi degli uccelli canterini di Erone, delle anatre di Vaucanson o del Turco Meccanico di Maelzel. L’intelligenza naturale presenta una delle sue caratteristiche più pregiate e utili nel calcolo? Non stupisce allora che le prime generazioni di computer si siano concentrate sulle loro prestazioni computazionali. L’intelligenza naturale è legata al linguaggio e al sapere? E le generazioni più recenti di calcolatori hanno dato (o tentato di dare) il loro meglio proprio in questi ambiti. Stando così le cose, ci vuol poco a ritrovare nell’artificiale una iperbole e una mimesi di una porzione del naturale.
Volontà e sensibilità come discrimine essenziale
Molto più utile è però la ricerca delle differenze. L’intelligenza naturale, e soprattutto il contesto in cui è posta, differisce da quella artificiale non per qualche spirito infuso, ma perché è espressione della nostra esistenza, che non consiste solo nel pensare, ma nel volere e nel sentire, dunque anche nel parlare, nel maneggiare attrezzi, nel produrre artefatti, nello sperare e nel rimpiangere.
Certo la mente, che nella sua forma elementare – dunque fondamentale ed essenziale –, tanto negli umani quanto negli automi, è memoria (mens, in latino), capacità di registrare e di trarre vantaggio da quanto si è registrato, può essere emulata in una sua funzione, ma non in tutte. Sicuramente, e per un motivo non tecnologico ma fisiologico, non nelle volizioni prima che nelle emozioni; e sappiamo bene che le patologie nelle quali il controllo della volontà e della sensibilità (nel senso soggettivo e oggettivo del genitivo) risulta compromesso rendono chi ne è affetto molto simile a una intelligenza artificiale2, perciò piuttosto difettoso come umano.
Così, come molti hanno rilevato3, l’inferiorità della computazione, del linguaggio e del sapere umano risulta ampiamente compensata (o più esattamente riceve un diverso significato) dalla presenza della volontà e della sua sorella minore, la sensibilità – che accoppia il sapere con un mondo percepito, amato o odiato, familiare o estraneo, e dota dunque l’esperienza di un significato.
Premetto sempre la volontà alla sensibilità perché non c’è nessuno, filosofo o non filosofo, che non abbia notato che un umano e un castoro sono più sensibili di un forno a microonde o di un telefonino.
Quello che però si è rilevato molto di meno – passati i tempi di Kant, Schopenhauer e Nietzsche – è il ruolo centrale che la volontà esercita nella vita e nella comprensione umana, giacché conferisce un senso, ossia una direzione, al sapere, al calcolo e al linguaggio. La nostra mente, infatti, non si compone solo di concetti, di categorie e di sensazioni. Possiede anche e anzitutto un impulso primario, assegna i fini all’intelligenza umana, trasformandola (quando va bene) in ragione, o (quando va male) in volontà di potenza. Cioè le conferisce quei motivi che mancano, e mancheranno per sempre, al burattino, che alla fine ubbidisce ai voleri del burattinaio.
Dunque, e questa è la mia tesi fondamentale, le volizioni, prima ancora che le emozioni, sono ciò che, nel profondo, distingue l’intelligenza naturale dalla sua sorellastra artificiale, che quando pure divenisse capace di riprodurla alla perfezione, o di superarla (in molti casi è già così, e dai tempi della carta e della matita), lo farebbe solo come un’imitazione difettosadella forma di vita umana. E difettosa perché difettiva proprio della volontà, che nella vita umana (così come nella vita degli organismi in generale) esercita, come spero di dimostrare, una sovranità assoluta, giacché anche la sua legislazione, per così dire, costituzionale, ossia la ragione, ne è una metamorfosi e una emanazione rara.
La proiezione umana verso il futuro
Questa volontà non dà forma al mondo – come pensavano, ognuno a suo modo, i tre illustri filosofi che ho menzionato un attimo fa –, ma può dar senso a un’esistenza che, in quanto tale, non ne possiede, essendo priva di una ragione che la ecceda: la rosa fiorisce senza perché; così ci appare guardandola dall’esterno, ma è altrettanto vero, da un punto di vista interno, che un fine ce l’ha eccome, ed è sfiorire più tardi possibile. Per noi umani non è molto diverso. Come scriveva Sartre disegnando i due volti di una sindrome maniaco-depressiva e prendendo partito per la depressione? «È la stessa cosa, in fondo, ubriacarsi in solitudine o condurre i popoli. Se una di queste attività è superiore all’altra, non è a causa del suo scopo reale, ma a causa della coscienza che possiede del suo scopo ideale; e in questo caso il quietismo dell’ubriaco solitario è superiore alla vana agitazione del conduttore di popoli»4. Basta un niente, insomma, per trovarci a guardare il mondo come se ci fosse scappato di mano. Perché siamo noi umani, e in certe condizioni – la potenza della routine, l’illuminazione di uno stato di grazia, lo stolto ma infaticabile ottimismo della volontà… –, che ci riveliamo capaci di dare un senso a quello che c’è e persino a noi stessi.
Come è possibile? E perché sarebbe possibile proprio a noi? Si consideri, ad esempio, quanto segue. Studi molto recenti5 hanno rilevato che i Large Language Model sono perfettamente in grado di capire i sottintesi e le ironie, così come di capacitarsi di aver fatto una gaffe. Cose che sembrerebbero prerogative degli umani, e nemmeno di tutti. Però c’è qualcosa in cui sono più deboli di noi: appaiono più conservativi e meno capaci di proporre soluzioni.
Questa circostanza viene solitamente spiegata con due argomenti: il primo è che l’intelligenza artificiale conosce solo il passato, e il secondo è che l’intelligenza naturale possederebbe una qualità magica, la «creatività». Tuttavia, se ci riflettiamo un istante, anche noi, proprio come le macchine, non conosciamo se non il passato. In questo momento so solo quel che mi è successo sinora, e niente più. Diversamente dalle macchine, però, noi siamo, per così dire, scaraventati in avanti dal bisogno, dalla speranza, dalla paura, e questo comporta la proiezione del passato e del presente verso il futuro, come ci hanno insegnato Agostino, Husserl e il fatto che a una cert’ora qualcuno chiede «cosa facciamo stasera?» o, patriarcalmente, «cosa c’è per cena?». Questa proiezione verso il futuro, di cui la creatività è una manifestazione rara e dubbia (bisogna risolvere dei problemi, ma non è detto che ci riusciamo), è ciò che ci impone di non accontentarci della conoscenza del passato e di impegnarci nel mestiere di vivere, che è prima di tutto dare senso.
La teoria della mente incarnata e finalizzata
È una impresa non ovvia, né sempre coronata da successo, ma accessibile solo a noi in quanto situati in un mondo, portatori di abilità, di cognizioni, e di finalità. E se nei titoli dei miei capitoli parlo di «mente», anziché di «intelligenza», è per indicare una sfera in cui l’intelligenza, con le sue componenti meccaniche, si incontra con l’anima, il principio che vive, vuole e ci affratella con tutti gli altri organismi, e che nel caso di alcuni di questi, tra cui l’animale umano, non consiste solo nel livello vegetativo, sensitivo e volitivo, ma anche in quello intellettuale e razionale. Perché ciò che intendo indagare è una sfera che non si limita al semplice, e più o meno quantificabile, ambito del calcolare, ricordare e correlare, ma investe il radicamento corporeo del pensiero e dei sentimenti (la mente incarnata), il potenziamento delle dotazioni naturali per opera della tecnica in quanto genesi dello spirito (la mente attrezzata), l’inserimento del pensiero nel sapere (la mente capitalizzata, l’intelligenza in senso stretto che trae vantaggio dall’accumulo delle conoscenze), oltre che la tensione e la volontà, l’avere dei fini e il perseguirli (la mente finalizzata, la ragione).
I sei argomenti fondamentali della distinzione
È con questi quattro colori, a cui ne premetto un quinto, la fenomenologia (il confronto tra l’intelligenza naturale e l’intelligenza artificiale), che cerco di dipingere una teoria. Sono ovviamente consapevole che quella che chiamo disinvoltamente «la mia teoria», così come si dice «la mia vigna» o «il mio bancomat», è debitrice di molte altre, con le quali cercherò di sdebitarmi almeno in nota. Che lo si creda o meno, mi sarei volentieri astenuto dall’infliggere a qualche volenteroso ancora una teoria della mente; ma il punto è che non si possono prendere le misure di quell’evento immenso e onnipresente che è oggi l’intelligenza artificiale se non partendo da qualcosa di ancora più grande e ubiquo per noi, ossia l’essere nel mondo degli umani. Cercherò di farlo svolgendo sei argomenti fondamentali.
Il primato della volontà sull’intelletto
Primo, che – d’accordo con quanto detto sin qui – il carattere distintivo dell’organismo in generale, e dunque anche dell’intelligenza naturale, è il primato della volontà sull’intelletto. Quanto dire che nel rapporto tra anime, gli organismi, e automi, i meccanismi, la mossa di apertura spetta sempre all’anima, in quanto portatrice di bisogni e dunque di volontà e di razionalità, e non all’automa, come sostengono coloro che, per lavarsi dei loro peccati, lamentano il dominio della tecnica6.
L’artificiale ci permette di riconoscere meglio la fisionomia del naturale
Secondo, che è almeno dal tempo, in effetti immemorabile (quando sarà iniziata questa storia?), in cui la scrittura si è fatta avanti nella vita umana, che disponiamo di una intelligenza artificiale e negoziamo con lei. Ora, in tutte le sue versioni, quella artificiale è una mente imitata (Turing non parlava forse di «gioco dell’imitazione»?)7, ma la mimesi – e talvolta la caricatura – offerta dall’artificiale ci permette di riconoscere meglio la fisionomia del naturale.
Intelligenza naturale e corpo
Terzo, che la specificità della intelligenza naturale – non solo umana, ma di ogni vivente – consiste nell’essere situata in un corpo; ed è proprio la circostanza di essere una mente incarnata che traccia la differenza essenziale tra naturale e artificiale. Pensiero è ciò che si trova in un corpo, e le manifestazioni del pensiero, sulle pareti di una caverna o nella memoria di un computer, non sono l’estensione della mente, bensì la sua registrazione. Da questa capitalizzazione si potrà ricavare altro pensiero (ognuno di noi è erede di una cultura), ma perché ciò avvenga è necessaria la pressione di un bisogno, di una volontà o di una ragione.
La mente umana è attrezzata, non un utensile
Quarto, che la mente umana, emergendo da un organismo capace di usare sistematicamente degli apparati tecnici, è una mente attrezzata, ossia si apre a modalità d’uso come tali precluse all’intelligenza artificiale, che è un utensile, laddove la mente umana è capace di sviluppare tecnologie. Siamo umani in quanto siamo animali e siamo animali più complicati, più felici e più infelici degli altri, perché disponiamo – in noi e soprattutto fuori di noi – di automi molto potenti, di tecnologie che si chiamano fuoco, ruota, stazione eretta, linguaggio, educazione e cultura.
Una mente finalizzata, dotata di scopi interni
Quinto e sesto, che la mente umana, nell’incontro con la tecnica, genera il mondo dello spirito, che si specializza come mondo del sapere in quanto epistemologia, e genera quella che definisco mente capitalizzata, la mente che fa tesoro di un passato non solo suo, ossia del mondo dello spirito. Soprattutto, la tensione del vivente, a differenza della inerzia delle macchine, manifesta l’aspetto più caratteristico della volontà in quanto tratto distintivo della vita umana: il fatto che la nostra sia una mente finalizzata, ossia dotata di scopi interni, di questioni di vita o di morte, e non semplicemente di scopi esterni, come avviene agli automi.
La pelle come metafora dell’irriducibilità umana
Il fine, alla fine, è la sola cosa che conta. Ciò che fallisce nel «gioco della imitazione» è conferire al burattino la volontà del bambino: questa bestia insaziabile, e non altro, è il vero e insuperabile discrimine tra il naturale e l’artificiale. La pelle, insomma, quella che dà il titolo a questo libro, non è solo la sede della sensibilità8. È anche, in quanto involucro vivente di un organismo volente, quella che si vuol vendere cara, al prezzo più alto possibile, in ogni momento della nostra vita; che ci attira verso un altro vivente per imperscrutabili questioni di pelle; o che può renderci amici per la pelle; o ancora quella che vorremmo fare o che vorremmo farci. Ossia è un impasto di sangue, sudore e lacrime che nessuna macchina potrà né vorrà mai imitare9. Ciò premesso, metto in attesa la pelle e passo al silicio.
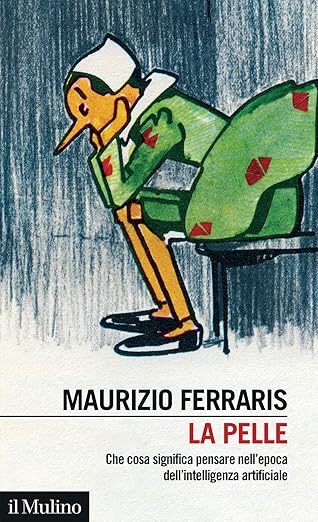
Note
1 Si devono a lui l’invenzione di uccelli meccanici che cinguettano, di anfore che cantano, di porte che si aprono automaticamente e di altre macchine progettate non solo con l’intenzione di stupire, ma anche, come nel caso degli uccelli canterini, di dare la parvenza della vita, cioè dell’anima.
2 A. Damasio, L’errore di Cartesio (1994), Milano, Adelphi, 1995.
3 La teoria della «mente incarnata» a cui farò riferimento nel secondo capitolo presuppone che si possa parlare di «mente» solo in presenza di corpo, e dunque esclude implicitamente che una macchina possa avere una mente (sebbene, aggiungo io, non esclude che una macchina sia in grado di effettuare calcoli intelligenti, il che è ovvio). Una critica della possibilità di un pensiero senza corpo più marcatamente teorica è quella presente in H. Putnam, Ragione, verità e storia (1981), Milano, il Saggiatore, 1995, cap. I. Si tratta di un esperimento mentale: uno scienziato pazzo mette un cervello in un bagno organico e lo stimola elettricamente. È possibile che il cervello abbia delle sensazioni, e dei pensieri a esse riferite, ma le sensazioni non si raffigurano veri oggetti nel mondo, sono semplicemente il risultato di stimoli elettrici, dunque il cervello non conoscerebbe il mondo, ma sé stesso.
4 J.-P. Sartre, L’essere e il nulla (1943), Milano, Net, 2002, p. 695.
5 J.W.A. Strachan et al., Testing theory of mind in large language models and humans, in «Nature Human Behaviour», 2024, 8, pp. 1285-1295, https://doi.org/10.1038/s41562-024-01882-z.
6 L’ipotesi della dittatura della tecnica è stata avanzata da Albert Speer nella sua dichiarazione finale al processo di Norimberga, il 1o settembre 1946 (https://www.youtube.com/watch?v=vyHWpubyv4I). Il testo in traduzione italiana è riportato in A. Speer, Memorie del Terzo Reich (1969), Milano, Mondadori, 1995. Pochi anni dopo Heidegger riprenderà il tema del dominio della tecnica conferendogli autorevolezza filosofica; cfr. M. Heidegger, L’impianto (1949), in Id., Conferenze di Brema e Friburgo, Milano, Adelphi, 2002. Questa visione fatalistica e autoassolutoria si trova in F. Kittler, Gramophone Film Typewriter (1986), Stanford, Stanford University Press, 1999, così come in K. Kelly, Quello che vuole la tecnologia (2010), Torino, Codice, 2011, e in tanti altri libri, articoli e discorsi quotidiani.
7 «Il gioco della imitazione» è il titolo del primo paragrafo di uno storico articolo del 1950 apparso su «Mind», in cui Alan Turing presenta quello che correntemente si chiama «test di Turing», il cui nocciolo è che se una macchina può far credere a un umano di pensare, allora pensa. Per l’articolo in questione e per una chiara e sintetica esposizione delle congetture filosofiche sulla intelligenza artificiale dovuta a Diego Marconi cfr. A. Turing, Macchine calcolatrici e intelligenza (1950), Torino, Einaudi, 2025.
8 Su cui ho già scritto a sazietà (almeno mia). Cfr. M. Ferraris, L’immaginazione, Bologna, Il Mulino, 1996; Id., Estetica razionale, Milano, Cortina, 1997.
9 Per una prospettiva che condivide molti di questi aspetti cfr. P. Legrenzi, L’intelligenza del futuro. Perché gli algoritmi non ci sostituiranno, Milano, Mondadori, 2024














































